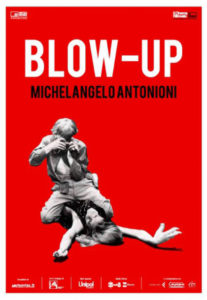 Sinossi: Londra, un fotografo di moda crede di aver visto (e fotografato) un omicidio. Cerca di arrivare alla soluzione del mistero, ma non ci riesce.
Sinossi: Londra, un fotografo di moda crede di aver visto (e fotografato) un omicidio. Cerca di arrivare alla soluzione del mistero, ma non ci riesce.
La tipologia filmica in cui si inquadra Blow up è legata a un principio di ossessione. Come in due grandi film “d’autore” come il capostipite La finestra sul cortile (1954) e La conversazione (1974), vero e proprio equivalente “sonoro” del film di Antonioni, la scoperta casuale di un particolare apparentemente insignificante innesca un percorso di detection inarrestabile che non sembra sorretto su nulla se non su un’ossessione patologica del protagonista.
Nel capolavoro di Michelangelo Antonioni, ispirato al racconto Le bave del diavolo dell’argentino Julio Cortázar, il regime scopico di tipo cinematografico raggiunge in la propria completa trasparenza, perché costruito proprio sulla piena identificazione con il soggetto interno alla scena, assecondando nel migliore dei modi un rapporto voyeuristico tra pubblico e film. Lo spettatore si abbandona al voyerismo al quadrato della visione, (abbastanza) sicuro di non poter essere chiamato in causa dall’oggetto del suo sguardo, potendo godere anche delle situazioni più sinistre e pericolose e compiendo lo stesso percorso di detection dell’eroe protagonista che lo spinge a volere vedere sempre di più, costi quello che costi. La partecipazione scopica può quindi dispiegarsi al suo meglio implementando l’efficacia della suspense che lavora sempre sulla polarità rischio-sicurezza.
D’altra parte, se è vero che l’identificazione secondaria al cinema è fondamentalmente un’identificazione al personaggio come figura del simile nella finzione, si sarebbe in errore a ritenere che la suspense derivante da una situazione voyeuristica sia l’effetto dell’empatia che si può provare per questo o quel personaggio; si tratta piuttosto del processo inverso per cui non è per simpatia che ci si identifica a qualcuno, ma al contrario la simpatia, e la conseguente dinamica di suspense tipica della tipologia filmica in questione, nasce solamente dall’identificazione, veicolata attraverso un sapiente utilizzo di marche sintattico-narrative che opacizzano in continuazione quello che stiamo vedendo. La simpatia è dunque l’effetto, e non la causa, dell’identificazione e dell’eventuale situazione di suspense, perché più aumenta la precisione del dettaglio, più la storia avanza, meno spettatore e personaggio vedono e capiscono.
Certo, è difficile considerare Blow up soltanto un film di suspense, nonostante l’elemento della detection sia fortemente presente nella costruzione della trama. Il protagonista è un fotografo brillante e di successo, un po’ anarcoide e decisamente insoddisfatto della propria esistenza, un tema caro ad Antonioni: basti pensare al David Locke di Professione: reporter (1975).
Un giorno fotografa una coppia che si bacia in un parco, la ragazza lo scopre e gli chiede insistentemente il negativo delle foto. Un po’ per curiosità, un po’ per pungolo, l’uomo non glielo consegna e anzi comincia a essere ossessionato da quelle che, all’inizio, ci sembrano soltanto delle banali fotografie. Improvvisamente da dentro l’immagine emerge un’altra storia: quella di un possibile omicidio. Sono le premesse di un giallo classico. Ma quell’immagine apparentemente anodina si è come cristallizzata, al suo interno sono presenti più determinazioni, che fanno letteralmente esplodere l’impianto e le possibilità narrative del film. La narrazione, nata quasi per caso, rimane abortita, non raggiunge mai lo statuto di una storia, con un inizio, uno svolgimento e un epilogo. Le foto vengono rubate, e il cadavere scompare, ma non c’è una soluzione della vicenda. Il film comincia a girare a vuoto, rimane letteralmente sospeso e irrisolto, come l’esistenza del suo protagonista. In questo senso la scena finale, nella quale un gruppo di mimi sta simulando una partita a tennis, è emblematica: il personaggio interpretato da David Hemmings potrà conciliarsi con la propria esistenza solo riuscendo a venire a patti con la finzione sulla quale si fonda, un atto di credenza intersoggettivo nel quale la pretesa oggettività della realtà si è come dileguata. Così potrà partecipare anche lui a quel gioco di finzione che si chiama realtà, e restituire la pallina invisibile ai mimi-giocatori.
Hemmings alla fine deve arrendersi (e noi con lui). Il fotografo, abituato a rubare paesaggi, volti, rappresentazioni della realtà, si rende conto che le immagini non sono sufficienti per guardare e decifrare ciò che ci sta intorno. La realtà non si risolve semplicemente in ciò che ci sembra di vedere, ogni sua rappresentazione rimanda a un’ulteriorità, è sempre infinitamente zoomabile, più ci avviciniamo all’oggetto della visione meno paradossalmente riusciamo a vedere. Ecco, quindi, i mimi giocatori del celebre finale e la scelta di Hemmings di raccogliere la pallina virtuale. Non vediamo nulla ma dobbiamo credere ugualmente a questa realtà, accettiamo il gioco, finalmente consapevoli della nostra finitezza e transitorietà.
Ti è piaciuto l'articolo? Iscriviti alla newsletter
Inserisci la tua email e riceverai comodamente tutti i nostri aggiornamenti con le novità, le anticipazioni e molto altro.
Compra su Amazon
- Drammatico
- Restaurato In Hd





