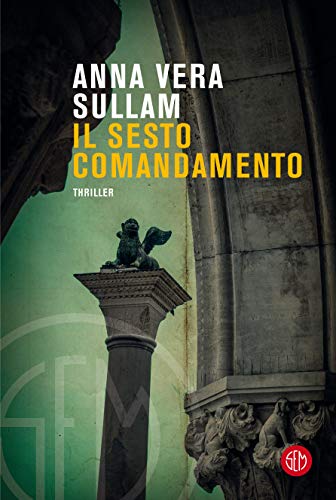Quanto generoso è un recensore? Fateci caso. È uno dei compiti, il suo (mestiere no, lo abbiamo già detto) più altruisti ed ecumenici che possiate immaginare. Quanto meglio lavora lui, tanto più vende l’autore che ha presentato. Incredibile. Eppure ci sono persone che dal leggere, approfondire, dissodare un testo altrui traggono un grande piacere, amplificato dagli echi che riescono a ricavarne. Una è qui e può garantirvi che una delle soddisfazioni maggiori per i recensori è reincontrare un personaggio ed il suo autore.
Questa è la premessa per parlarvi de Gli occhi della notte, nuovo romanzo di Marina Visentin, che torna alla nostra ribalta dopo quel fortunato Cuore di rabbia di cui ho avuto modo di dilettarmi un paio di anni fa ( e in video) e con Marina torna ovviamente anche la (alla milanese, con l’articolo) Giulia Ferro, sua protagonista-alter ego ma non troppo, stavolta impegnata in un caso davvero efferato.
Due parole di presentazione, per chi non conoscesse questa formidabile coppia di donne, così accomunate sulla carta e così diverse nella vita reale.
Entrambe sono laureate in filosofia – e la Visentin ci cosparge la narrazione di splendidi accenni tratti da quegli studi, citando per esempio la colomba di Kant (andate a pag. 33), Nietzsche e l’abisso (pag. 148), Epicuro e la morte (pag. 218) così inorgogliendo la sua trama a dimostrazione che il giallo non è affatto letturina da edicola della stazione.
Entrambe camminano molto, e questa passione è espediente per tratteggiare descrizioni, episodi e notizie sul quartiere prescelto (stavolta siamo ad Affori, periferia graziosa e borghese con una sua perdurante personalità autonoma tipica del borgo solo successivamente inglobato in città), così godibili da avermi fatto affermare, durante la puntata di Risolto Giallo a cui Marina è tornata a presentare questo libro che potrebbe essere usato anche come guida turistico-letteraria della zona.
Entrambe leggono molto, nuotano, sono ostinate e con gran senso di giustizia ma divergono, eh sì, mica uno scrittore si può clonare nel personaggio, sia perché Marina si autodefinisce una gran romanticona mentre Giulia è dura e spiccia (anche se a occultare la sua vulnerabilità) e sia perché la Visentin è critico cinematografico e la sua vicequestore non entra in una sala da decenni.
Ciò tutto premesso, la trama è anticipata nello stesso primo capitolo: viene trovato il cadavere di una bimbetta di sette anni, Cinzia, scomparsa mentre giocava al Parco sorvegliata dalla sorella (o quasi, perché era lì anche il fidanzatino, quindi forse l’attenzione a tratti scemava).
Fatto oscenamente rivoltante già in sé, aggravato dalla circostanza che la bimba – un attimo prima sullo scivolo o l’altalena – un attimo dopo volatilizzatasi senza che nessuno abbia visto nulla. Nessuno, e niente. Non ci sono occhi (ecco il titolo), né umani né artificiali (grande lavoro sul funzionamento delle videosorveglianze urbane quello dell’autrice qui) che abbiano seguito Cinzia nell’attimo in cui è sparita.
Un’indagine in stallo, quella di Giulia e della sua squadra, fatto già strano per la letteratura gialla che conosce più il tema della falsa pista, del colpo di scena, del ribaltamento di ruoli ma che invece qui vive l’angoscia e la frustrazione dell’inquirente bloccato in punti morti, in piste investigative inconcludenti, depistato dalle bugie “colpose” dei testimoni in buona fede. Un fraseggio tra loro che trasuda l’altalenare tra entusiasmo di fronte ad un nuovo indizio e crollo della speranza quando si rivela irrilevante, il tutto condito dal pressing di superiori che- ut plerumque accidit nella vita di tutti i giorni- sono gerarchicamente sovraordinati, e quindi pretendono di dispensare ordini e mietere risultati, ma qualitativamente molto sovrastimati.
Giulia, Alfio e gli altri componenti della squadra procedono ostinatamente verso un finale inatteso e mozzafiato, e lo fanno parlando tra loro in un modo che la Visentin è maestra a rendere: parlano in modo verosimile, parlano come parliamo noi, sottintendendo quello che sanno già, riprendendo più avanti quel non detto che trova forma, abbreviando i concetti ed evitando gli spiegoni. Una tecnica che a mio papà ha fatto tornare in mente proprio quella cinematografica, di cui Marina è critica: flashback, zoomata, scena attuale, telecamera che si allontana. A me ricorda Quentin Tarantino.
Una storia cruda e illividita come la Milano in cui ambientata, dove alla spiattellata normalità di una famiglia dove l’aggettivo “allargata” non moltiplica affetti ma contrappone in modo raccogliticcio i sentimenti reali delle persone: chi sordocieca in nome del modellino Mattel, chi biasimante ancora dopo anni, chi arrogantemente convinto di avere tutto sotto controllo. E, nel frattempo, Cinzia muore.
Ti è piaciuto l'articolo? Iscriviti alla newsletter
Inserisci la tua email e riceverai comodamente tutti i nostri aggiornamenti con le novità, le anticipazioni e molto altro.