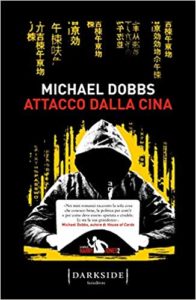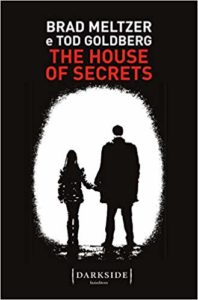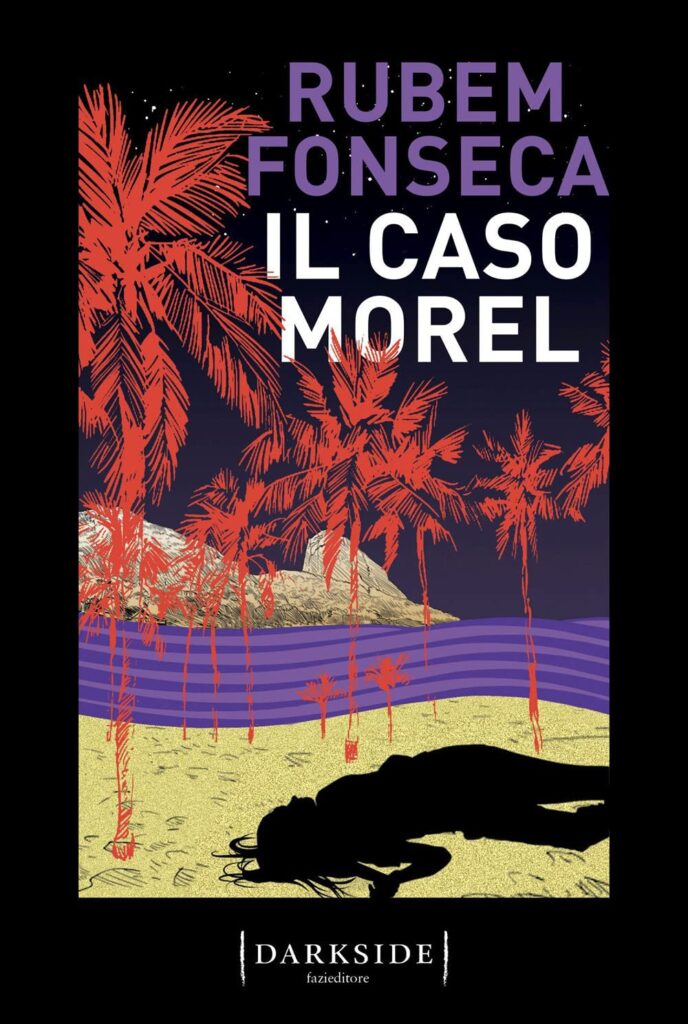Oggi al bancone del Thriller Café abbiamo in serbo un libro molto speciale per voi: “Gli unici indiani buoni”, dell’autore nativo americano Stephen Graham Jones, recentemente edito da Fazi nella mai abbastanza osannata collana Darkside, che da qualche anno a questa parte ci offre il meglio del noir e del thriller internazionali.
“Gli unici indiani buoni” allude a una celebre frase che si dice fu pronunciata per la prima volta dal generale Philip Sheridan ai tempi delle Guerre Indiane, nel vecchio West: “l’unico indiano buono è l’indiano morto”. La scelta di un titolo del genere, da parte di un autore nativo americano con radici nella tribù dei Piedi Neri, denuncia già lo stile dell’opera: ironico e amaro al tempo stesso.
Il romanzo, in effetti, parla di indiani, quattro in particolare: Lewis, Gabe, Ricky e Cassidy. Cresciuti in una riserva ai confini del Canada, non hanno arco e frecce o diademi di piume. Nati quasi un secolo dopo le cariche della cavalleria e il genocidio dei loro antenati, combattono le loro battaglie quotidiane contro nemici più subdoli ma altrettanto mortali: alcolismo, diabete, incidenti d’auto, discriminazione sociale, galera. “Veniamo da dove veniamo… e le cicatrici sono comprese nel prezzo, no?”. Alla soglia dei quarant’anni, fanno del loro meglio per sopravvivere, con lavori più o meno precari e famiglie più o meno strutturate, ma c’è un’ombra del loro passato che torna a tormentarli. Tanti anni fa, durante una battuta di caccia, qualcosa andò storto, e ora c’è qualcuno, o qualcosa, che vuole regolare il conto… Il primo a morire è Ricky Boss Ribs, massacrato nel parcheggio di un pub. Sembra solo una rissa tra ubriachi, ma perché gli occhi di Ricky, prima di chiudersi per sempre, vedono il parcheggio invaso da cervi wapiti? Chi sarà il prossimo a morire?
A voler essere rigorosi, più che un thriller il romanzo di Stephen Graham Jones è un horror a tutti gli effetti, in quanto contiene elementi soprannaturali tratti dal folklore nativo. L’autore attinge dalla memoria ancestrale dei Black Feet e porta in vita l’antico e inquietante archetipo della Donna Cervo, mettendolo però in tensione dialettica con la vita moderna, fino al punto di farlo interagire nella più allucinante partita di basket che abbiate mai letto.
Come tutte le grandi opere, “Gli unici indiani buoni” è un romanzo che si legge su più livelli, e che funziona su ciascuno di questi. La trama narrativa, pur essendo estremamente avvincente, è soltanto un pretesto per oltrepassare i confini del genere e raccontare che cosa significhi essere “indiani” oggi, e tutte le contraddizioni e le difficoltà che ciò comporta. A questo proposito, è davvero simbolica la lunga scena che descrive la preparazione e il rituale all’interno di una capanna sudatoria improvvisata, costruita alla bell’e meglio con coperte dei cani. I personaggi di Graham Jones cercano di riappropriarsi della loro identità in un mondo, quello contemporaneo, che l’ha triturata e cannibalizzata. L’uomo bianco e il capitalismo hanno infine vinto la loro battaglia: con le armi prima e con l’orrore delle “boarding schools” dopo, che hanno seviziato migliaia di bambini con fine di “uccidere l’indiano per salvare l’uomo”, cancellando la memoria della lingua antica e la stessa identità culturale dei nativi. Il lavoro di Stephen Graham Jones è al tempo stesso un grido ribellione e un atto creativo che trasporta la tradizione in un ambito postmoderno, infondendole nuova vita. “Aveva sempre voglia di lanciare un grido così, di quelli che, a un certo punto, quando si fosse voltato per affrontare i bianchi, gli avrebbero dato la sensazione di impugnare un tomahawk. Di avere il viso dipinto a chiazze bianche e nere, screpolate e minacciose…”
Stephen Graham Jones è davvero uno scrittore davvero eccezionale, senz’altro una delle voci più originali e interessanti tra quelle che ho avuto il piacere di leggere negli ultimi anni. Per rendervene conto, basterà il primo capitolo: un vero pezzo di bravura, un allucinato e iper-dinamico flusso di coscienza che non lascia respiro. Il traduttore Giuseppe Marano merita un elogio, per aver saputo traghettare nella nostra lingua uno stile così denso di riferimenti e sott’intesi che non sempre sono facili da cogliere. C’è qualcosa, nel fraseggio di Jones, che fa venire in mente David Foster Wallace, ma senza nessuna pretenziosità o intellettualismo. Un altro riferimento che mi viene in mente, sia per lo stile che per le tematiche è Tommy Orange, anch’egli nativo con origini Cheyenne e Arapaho, con il suo “Non qui, non altrove”, una lettura che mi sento di consigliare caldamente.
Che altro aggiungere? Forse un po’ di musica! Vi consiglio di abbinare la lettura all’ascolto di “Music for the Native Americans” del mitico Robbie Robertson, membro della Band (c’è bisogno di aggiungere altro?) di origini Mohawk.
Buona lettura!
Ti è piaciuto l'articolo? Iscriviti alla newsletter
Inserisci la tua email e riceverai comodamente tutti i nostri aggiornamenti con le novità, le anticipazioni e molto altro.