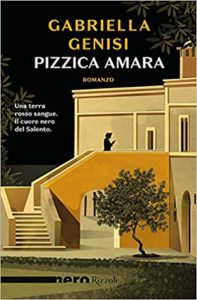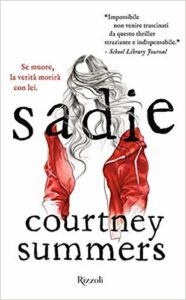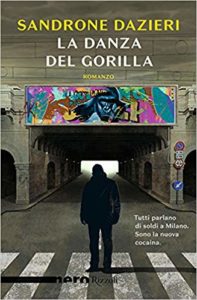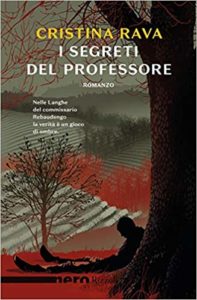Martin Rua nasce a Napoli nel 1976 e si laurea, sempre a Napoli, in Scienze Politiche. Numerose sono state le sue passioni che l’hanno portato ad approfondire studi in antropologia culturale, storia delle religioni, in esoterismo e alchimia e lui, nel suo blog, si definisce in questo modo: “Scrivo. Invento. Scopro. Racconto.”
Il suo percorso editoriale inizia con il romanzo Le nove chiavi dell’antiquario (2013) che è il primo romanzo della Parthenope Trilogy il cui protagonista, Lorenzo Aragona, è un mercante d’arte. Seguiranno i romanzi La cattedrale dei nove specchi e I nove custodi del sepolcro e tanti altri fino a giungere, nel 2020, al nostro, qui recensito, Il cacciatore di tarante.
1870. Siamo a Torino dove il primo dei nostri protagonisti, l’ispettore di pubblica sicurezza Giovanni Dell’Olmo, è alle prese con un’indagine che lo porta sulle tracce, nel quartiere malsano denominato moschino posto sulle rive del Po (oggi Borgo Vanchiglia), di un assassino di prostitute chiamato l’Imbalsamatore. Purtroppo l’assassino gli sfuggirà e i suoi superiori, quasi come una sorta di punizione, lo inviano ad indagare nel Salento e gli comunicano che verrà affiancato da un illustre tossicologo ed esperto di ragni: il napoletano dottor Carlo Caracciolo de Sangro duca Di Martina Franca. Così questi due personaggi, agli antipodi tra di loro, il primo piemontese, snob, freddo, scostante, moderatamente razzista, che manifesta affetto solo per i propri cani da tartufo, la madre, la sorella e il defunto padre parlamentare del Regno Sabaudo e il secondo napoletano, nobile, borioso, nostalgico dell’ormai tramontato Regno delle Due Sicilie ma anche solitario e ombroso si troveranno a confrontarsi, o meglio all’inizio a scontrarsi, in un’Italia appena formata ma che è ancora ben lontana da aver formato gli italiani. La destinazione della loro missione è il paese immaginario di Ariadne, nei dintorni di Nardò, nel profondo Salento devoto al Santo Paolo dove nel giro di pochi mesi cinque donne, tutte braccianti nei campi di una masseria, sono state “calate”, cioè pizzicate, dalle tarante e in seguito sono morte. Al loro arrivo troveranno ad accoglierli una parata di personaggi locali (il sindaco, il parroco, il maresciallo dei Carabinieri e il medico condotto) che, a vario titolo, si riveleranno tutt’altro che accoglienti perché non vedono di buon occhio l’arrivo di questo “straniero e mezzo” e cioè del torinese Dell’Olmo e del duca che in realtà è mezzo ariannese (per parte di madre). I due, rendendosi conto fin da subito che queste morti sono alquanto sospette, dovranno per indagare metter da parte la loro iniziale diffidenza per l’altro e stringersi metaforicamente la mano in un patto di alleanza che li porterà a collaborare al fine di districarsi nel dedalo di misteri che andranno via via emergendo a partire dall’arcaica, ma al tempo non ancora superata, leggenda pagana della Malombra. La Malombra, nelle credenze salentine, è una specie di demone vestito di nero che viene spesso identificato con una enorme taranta che infesta case e campagne e che ogni trent’anni, sempre secondo la leggenda, si ripresenta per reclamare il suo tributo di sangue. Questa superstizione si inserisce all’interno del cosiddetto “tarantolismo” che è una sorta di conflitto cosmico tra l’uomo, le sue paure e la natura e in Puglia essere pizzicati da un ragno, o calati come dicono lì, significa smarrirsi nell’ignoto lontani dalle angosce di una vita di stenti.
La metafora del labirinto all’interno di questo giallo è più volte rievocata sia perché i bambini per scacciare la Malombra praticano un rituale denominato dall’autore “katzizzo ‘on ascìo” (schiaccio l’ombra) girando in tondo sui labirinti unicursali disegnati sul pavimento delle chiese sia perché la stessa struttura che ha Ariadne è labirintica, sia perché, infine, i due protagonisti dovranno indagare all’interno di un vero e proprio labirinto di oscure credenze e superstizioni. Ma che cos’è, in realtà, questo labirinto che sta a cavallo tra l’esoterismo e la magia? In chiave psicanalita significa perdersi dentro se stessi per poi ritrovarsi ed è proprio quello che tutti i personaggi di questo giallo faranno raggiungendo, alla fine, una sorta di catarsi personale. Interessante è lo studio che l’autore ha fatto in merito alla lingua usata che va dall’italiano ad alcune espressioni piemontesi e napoletane a un dialetto salentino che è un miscuglio di vari dialetti del Salento (un po’ come fa il grande Camilleri con il suo siciliano) all’inclusione, inoltre, di alcune frasi in grico che è una forma di greco scritto con caratteri latini e parlato da pochissime persone in quella che viene denominata Grecìa salentina. Numerosi, oltre alla lingua, sono gli altri piani narrativi presenti nel libro: l’eccellente ricostruzione storica, il contrasto tra il Nord e il Sud, i rituali pagani e la scienza.
Senza spoilerare nulla posso però dire che di questi due personaggi che anche se hanno stretto tra loro una sorta di “pseudo amicizia” continueranno a rimanere sempre un piemontese e un napoletano con le loro visioni contrapposte di Stato e di organizzazione, perché sempre nel 1870 siamo, sentiremo ancora prossimamente parlare come ci rivela, in una sua intervista, lo stesso Rua. In conclusione di questo giallo/noir dal ritmo all’inizio lento e poi via via sempre più incalzante e dallo stile fluido e quasi cinematografico con dialoghi che da soli creano azione, non posso che dare un giudizio più che positivo.
Ti è piaciuto l'articolo? Iscriviti alla newsletter
Inserisci la tua email e riceverai comodamente tutti i nostri aggiornamenti con le novità, le anticipazioni e molto altro.