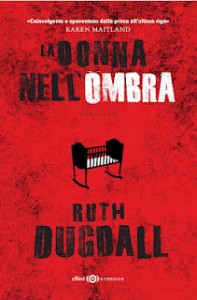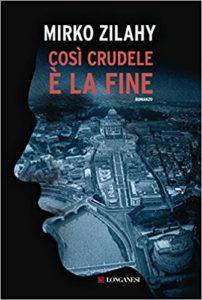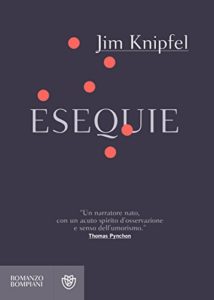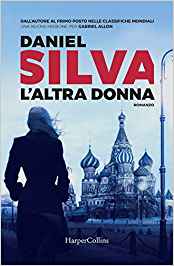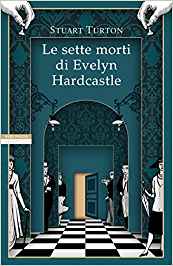 Un uomo riacquista contezza di sé all’improvviso. Sta correndo in un bosco, senza passato né futuro, in fuga. Non ha alcun ricordo, solo un nome gli sale alle labbra: Anna. L’uomo non sa chi sia, Anna. L’uomo non sa nemmeno chi sia lui stesso.
Un uomo riacquista contezza di sé all’improvviso. Sta correndo in un bosco, senza passato né futuro, in fuga. Non ha alcun ricordo, solo un nome gli sale alle labbra: Anna. L’uomo non sa chi sia, Anna. L’uomo non sa nemmeno chi sia lui stesso.
Questo è l’inizio del libro d’esordio di Stuart Turton, e non fa sconti al lettore. Lo proietta nel centro geometrico di una situazione della quale non si conoscono premesse e motivazioni. Come il personaggio principale, anche chi legge scopre la trama poco a poco, dal di dentro, in un caleidoscopico avvicendarsi di fatti, personaggi, snodi narrativi.
Il protagonista è intrappolato in un loop. Ospite in una casa di campagna nella quale verrà commesso un delitto, si sveglia ogni giorno nel corpo di un diverso invitato e vivrà per sette volte la stessa giornata, con il compito di trovare l’assassino. Solo risolvendo l’enigma potrà liberarsi dal circolo vizioso dell’eterna ripetizione di questo ciclo diabolico. La complessità estrema del romanzo, congegnato come un sistema d’incastri narrativi oliati alla perfezione, scoraggia dall’accennare qualcosa di più sulla trama. Da una parte sarebbe un torto nei riguardi del lettore, data la considerevole soddisfazione che l’intreccio è in grado di fornirgli semplicemente col suo dipanarsi, e dall’altra perché l’effetto sorpresa indotto dalle scelte formali e sostanziali operate da Turton è un elemento portante dell’intera architettura.
Da subito emerge la forte ibridazione di generi che caratterizza questo romanzo. L’intreccio attinge a stilemi della fantascienza, trapiantati nel contesto tipico (e forse stereotipico) del giallo d’investigazione, con un effetto straniante e seducente. Non a caso, il libro si apre con un (classicissimo per ogni amante del mystery) elenco degli invitati, subito preceduto dalla dettagliata mappa di Blackheath House, la villa di campagna teatro dell’oscura vicenda. L’atmosfera della casa e relativi dintorni è disturbante, angosciosa. Salta subito alla mente il senso di claustrofobia della villa e dell’isola di Dieci piccoli indiani, autentico nume tutelare che riaffiora di continuo. Come nel fondamentale romanzo della Christie, anche qui il protagonista tenta in ogni modo di eludere il proprio fato e allontanarsi dall’incubo soffocante che lo imprigiona. L’innesto della metempsicosi ciclica che lo porta nel corpo e, soprattutto, nella mente degli altri ospiti costruisce una stratificazione di mezzi narrativi di rara potenza. L’uomo senza nome dapprima domina e infine rischia di essere dominato dalle personalità sempre più forti con cui si misura. I corpi che lo ospitano non sono burattini da controllare a piacimento, ma sono mossi da emozioni, pulsioni e traumi man mano più difficili da asservire. Fanno resistenza, lottando contro l’anima che li invade, talvolta prevalgono su di essa. A giovarsi di questo e altri meccanismi, tutti precisamente iscritti in un sistema di regole chiaro fin da subito, è il ritmo della narrazione, in certi passaggi serrato, in altri meditativo.
Turton non commette mai peccato di mistificazione. Non imbroglia il lettore, non bara, non ricorre a espedienti. La sua narrativa è onesta, calibratissima, intarsiata in maniera molto più che meticolosa. È un capolavoro d’ingegneria. Per certi versi, ricorda le sceneggiature di certe produzioni ad alto budget che di recente hanno rianimato il panorama delle avventure videoludiche. Qui si realizza una seconda ibridazione. Il linguaggio dei moderni videogiochi d’avventura, che racconta finali multipli a seconda delle scelte del giocatore, presenta un elemento giocoforza estraneo a un romanzo, ossia l’interattività. Turton tuttavia metabolizza perfettamente la lezione che possono impartire questi adventure e compie il miracolo di replicarla nel suo libro. La trama sembra davvero costruita con un occhio alla possibile diramazione di molteplici linee narrative, ed emerge più volte il sospetto che sia stata elaborata applicando gli stessi metodi della scrittura di opere interattive. Se sia questa la chiave per riscoprire una vena d’originalità entro un genere molto codificato come il giallo, resta argomento di discussione: in fondo, il rischio di fallimento intrinseco a un’operazione del genere è alto. D’altra parte, Le sette morti di Evelyn Hardcastle è fresco, energico, per molti versi nuovo, e il rischio cui si accennava pare davvero scongiurato.
Altro fatto degno di nota in Evelyn Hardcastle è la presenza di una morale. Non è poi così scontato trovarne una in un mystery, non è scontata una così profonda riflessione sulle possibilità che un uomo ha di riscattarsi. Più volte Turton insiste sull’empatia provata dal protagonista nei confronti di persone e situazioni che lo circondano. Questa insistenza non è casuale, è essa stessa un indizio. Forse il vero colpo di scena non riguarda la soluzione dell’enigma, bensì la consapevolezza non solo di aver letto un ottimo giallo, ma di aver imparato una lezione importante.
Recensione di Alessandra Ghilardi e Alessandro Rossi
Ti è piaciuto l'articolo? Iscriviti alla newsletter
Inserisci la tua email e riceverai comodamente tutti i nostri aggiornamenti con le novità, le anticipazioni e molto altro.