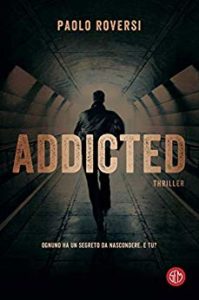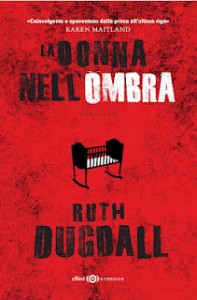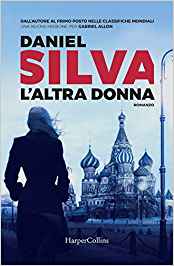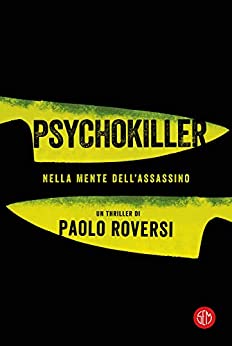
“Vietato barare con chi legge”.
Se provassimo a scucirgli una dritta per scrivere un buon giallo, Paolo Roversi, vecchia conoscenza del Thriller Café, risponderebbe con un sorrisetto furbo e questa sua personale reinterpretazione della prima tra le “Venti regole per scrivere romanzi polizieschi”, un prontuario pubblicato nel 1928 da S.S. Van Dine che esordisce con un consiglio ai novelli giallisti, un invito a sfidare il lettore senza imbrogli o macchinazioni, come in una regolare sessione di scacchi che si sviluppi tra paragrafi e punteggiatura: “il lettore deve avere le stesse possibilità del poliziotto di risolvere il mistero – afferma il maestro americano – tutti gli indizi e le tracce debbono essere chiaramente elencati e descritti”.
Semplice, diretto, lineare: nel poliziesco non si bluffa.
E Roversi non ha inteso bluffare in alcuna delle tappe che hanno segnato la sua ascesa a consolidata realtà del crime nostrano, distinguendosi tra gli specialisti per originalità e penna versatile: giornalista, romanziere per adulti e ragazzi, sceneggiatore, fondatore della web press e casa editrice digitale MilanoNera, un progetto nato e cresciuto a braccetto con il suo personaggio più famoso, lo scanzonato hacker dai natali brianzesi che risponde al nome di Enrico Radeschi e dà la caccia ai malviventi della Madonnina sfrecciando sull’intramontabile Vespa gialla (qui un tritticco di sue avventure: Alle porte della notte, La confraternita delle ossa). Stavolta però il “Giallone” di radeschiana memoria rimane confinato tra le mura del garage, perché l’autore mantovano di adozione meneghina sceglie di farsi scortare dal commissario Diego Ruiz lungo un tragitto che lo conduce alla pubblicazione di “Psychokiller – Nella mente dell’assassino” (S.E.M. – Società Editrice Milanese, 2020) e alla conseguente conquista del “Premio Scerbanenco 2020, Sezione Pubblico”, riconoscimento di assoluto prestigio nel panorama letterario di genere.
Una cupa Milano dei giorni nostri. La pioggia battente che infuria su un gelido febbraio. In centro, la movida sfrenata prolifera nelle dark room e ravviva gli aperitivi consumati su rooftop mozzafiato; al Naviglio della Martesana l’acqua riflette la luce fioca dei lampioni, il cappellaccio di un pescatore ostinato dondola tra il cemento e i ciuffi di erba fradicia. Il commissario Diego Ruiz, capo della Squadra Antirapine presso la Mobile di Milano, osserva il fiume attraverso la vetrata sporca di un caffè e minimizza a suon di bicchieri tre problemi tutto sommato trascurabili: la sua dipendenza dall’alcol, la continua emicrania e un colpo ad una banca di affari che lo ha impegnato per gran parte della giornata con rilievi e interrogatori. È il quarto cruccio che lo tormenta, piuttosto. In Questura gli hanno appena recapitato una busta gialla, asettica, anonima; sulla costola le sue credenziali scritte a macchina, all’interno una pendrive e un biglietto dal messaggio sibillino: “devi prendermi prima della fine del lavoro. Hai sette giorni”. La chiavetta USB contiene un video amatoriale di scarsa qualità. Ripresa sfocata in modalità notturna, immagini tremolanti. Dettagli annacquati dai colori verdastri e audio silenziato. In primo piano, mani guantate si stringono attorno al collo di un noto magistrato, che viene filmato mentre il suo esecutore lo strangola e sbeffeggia la polizia. Ha quindi inizio un’indagine inquietante e dai risvolti imprevedibili, un serrato tiro alla fune che strattonerà assassino e forze dell’ordine tra l’Italia e la Svizzera coinvolgendo anche la profiler Gaia Virgili, talentuosa criminologa emiliana in forza alla Unità di Analisi del Crimine Violento di Roma, che a colpi di aikido e perizie psicologiche tenta di affermarsi in una professione pervasa dal maschilismo.
“Il mondo degli uomini semplici si esaurisce al calare delle tenebre; il mio inizia in quel momento”, si ripete un mattino il commissario Ruiz, osservando allo specchio quel che resta di una delle sue colossali sbronze. Psychokiller setaccia esistenze simili alla sua, che navigano inquiete e lente nelle viscere della metropoli milanese, tra liquami, motel fuori porta e monolocali svaligiati. Lì, dove tre ceffi sputano e calano full in una bisca clandestina, una giovane civettuola artiglia con il tacco dodici lo sgabello di un club, la puzza di fritto e cipolla appesta i kebab del quartiere magrebino. In un acquitrino così distante dal jet set e le carte di credito di Galleria Vittorio Emanuele II, ristagnano le vicissitudini dei poliziotti implicati nella ricerca dell’omicida, che si trovano a rivaleggiare con un avversario scaltro e inafferrabile, in grado di mantenere un costante vantaggio sulla squadra inquirente e minare le certezze dei suoi componenti al punto di intrappolarli in un intreccio di sospetti reciproci che rischierà di farli capitolare.
L’ambientazione cinerea e aberrante, in uno con la scelta di marchiare la psicologia dell’antagonista tramite tratti complessi ed accattivanti, fa sì che il romanzo rispecchi a pieno i canoni del noir metropolitano, un sottogenere che sta faticando a radicarsi nel mercato librario italiano, sebbene in contesti internazionali abbia spesso fatto da apripista alla cavalcata di numerosi purosangue (si pensi a Ed McBain, James Ellroy e Jean Claude Izzo). Altrettanto valevole e calibrato si presenta lo stile narrativo, un efficace compromesso tra lo sprezzante Charles Bukowski di “Pulp” – autore alla cui produzione, peraltro, Roversi ha dedicato diversi anni di studio e tre volumi, uno dei quali addirittura a quattro mani con Fernanda Pivano – e l’impareggiabile maestria nell’impostazione dei dialoghi del primo Raymond Chandler: sobrio, asciutto, ruvido, al servizio di una trama complessa che non scade nel cervellotico, costellata da elettrizzanti colpi di scena e un finale mozzafiato, impreziosito da una repentina virata di punto di vista che disorienta e scaraventa il lettore nel baratro in cui vengono modellate le infinite forme del male, il subconscio umano:
“spinto dalla curiosità di sapere scendo di nuovo nella botola e mi siedo davanti allo schermo. Per qualche secondo fisso disorientato il fermoimmagine. Devo affrontare i miei demoni, scoprire la verità. Osservo lo schermo e non mi capacito di ciò che vedo”.
Soltanto una volta terminato il libro, mi accorgo di aver rimediato una cocente sconfitta.
La cosa mi secca, dato che succede di rado; o meglio, è inusuale che incassi disfatte come questa.
Percepisco la netta, imbarazzante sensazione che la soluzione del caso fosse in ogni momento a un palmo dal mio naso, rimpiattata tra le righe a farsi beffe di me, non in bellavista ma comunque accessibile applicando rigore logico e ragionamento deduttivo.
Ciononostante non ci ho capito niente.
Tra i due, chi legge e chi investiga, ha vinto quello intelligente: lo sbirro.
Mi ha stracciato giocando pulito, esattamente ciò che per le “Venti regole” di S.S. Van Dine equivale alla stesura di un ottimo poliziesco.
Ora sta a voi dimostrare di che pasta siete fatti: leggete, indagate, soffermatevi a ammirare il Balla che rallegra – si fa per dire – la camera da letto del commissario Ruiz.
Fate quello che ritenete utile per aguzzare l’ingegno insomma, basta che non bariate.
Mi raccomando, è la prima regola.
Altrimenti vi troverete sotto casa Paolo Roversi che sgassa in sella al Giallone.
E lui non perdona.
Recensione di Lorenzo Garzarelli.
Ti è piaciuto l'articolo? Iscriviti alla newsletter
Inserisci la tua email e riceverai comodamente tutti i nostri aggiornamenti con le novità, le anticipazioni e molto altro.