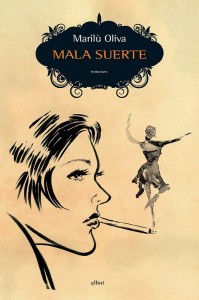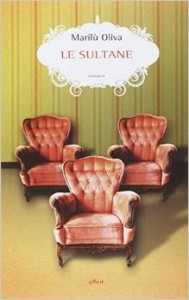 Ho letto tutto di Marilù Oliva. Dal suo primo “Repetita” alla trilogia della Guerrera (Tu la pagarás!, Fuego, Mala suerte). Le sue storie mi sono sempre piaciute, e il suo stile piuttosto fluido mantiene l’attenzione fino in fondo. Le due cose insieme catturano il lettore e fanno di Marilù Oliva una fra le migliori scrittrici noir del panorama italiano, però nel suo ultimo romanzo: “Le sultane” c’è decisamente un balzo in avanti. Un balzo verso la “grande letteratura”.
Ho letto tutto di Marilù Oliva. Dal suo primo “Repetita” alla trilogia della Guerrera (Tu la pagarás!, Fuego, Mala suerte). Le sue storie mi sono sempre piaciute, e il suo stile piuttosto fluido mantiene l’attenzione fino in fondo. Le due cose insieme catturano il lettore e fanno di Marilù Oliva una fra le migliori scrittrici noir del panorama italiano, però nel suo ultimo romanzo: “Le sultane” c’è decisamente un balzo in avanti. Un balzo verso la “grande letteratura”.
Non parlerò della trama; dico solo che è piuttosto fresca e avvincente, e poi di quest’opera ne hanno scritto un po’ tutti, e tutti hanno lasciato recensioni buone, spontanee, autentiche e soprattutto entusiaste. In questa mia le richiamo tutte, perché hanno detto quanto c’era da dire evidenziando tutti i punti di forza del romanzo, sottolineando più che bene le tematiche culturali e psicologiche, trattate dalla scrittrice. E non parlerò dello stile fluido e sarcastico e non starò a disquisire se “Le sultane” appartiene al genere noir, thriller, pulp, commedia o quant’altro. Voglio solo scrivere cosa mi è arrivato al cuore che non avevo previsto, o meglio, pensato di trovare in quest’opera.
A Wilma (una delle protagoniste) è morto un figlio in un incidente stradale. È morto nel fiore degli anni mentre correva con la moto e l’altra sua figlia è una donna stravagante e irrequieta. Il marito l’ha lasciata da tempo. Wilma adora suo figlio. Va a trovarlo spesso al cimitero. Il marmo bianco di un luogo silenzioso è l’unico legame che le resta. Si siede accanto alla sua lapide e gli parla. Ha il desiderio di regalargli una sepoltura gentilizia più bella e più grande, dove potrà magari mettere la sua moto. Quella motocicletta strumento di morte, ma che suo figlio amava tanto. Lo desidera, questo. E anche se dovrebbe odiarla, desidera lasciargliela accanto e fargli sentire il rombo del suo motore. Quando Wilma “afferrerà” dei soldi, quello della sepoltura sarà il suo primo desiderio da realizzare.
Marilù Oliva non si lascia andare a disquisizioni sul dolore di una madre. Questo dolore non è assolutamente descritto e il testo è privo di considerazioni sulla morte. Il dolore, il vero protagonista della vita di Wilma, la scrittrice lo lascia desolatamente intuire da piccole cose, spicci rimpianti, assenze, o semplici desideri. Piccole cose ho detto, ma del tutto profonde perché lasciano spazio ai fatti della sofferenza, e all’anima snaturata che sorda percorre a memoria i viali incipressati fino al luogo dove è sepolto il suo cuore. Wilma ha sempre il suo dolore nell’anima. Lo esterna poco, ma è sempre con lei. È implacabile perché è nelle ossa vuote della sua esistenza.
Nel trambusto della storia, nell’avvicendarsi a ritmo serrato dei fatti del romanzo (omicidio, paure, sospetti ecc.) e nel suo svolgersi parossistico dove l’azione non può lasciare spazio ad altro, Wilma avrà sempre un pensiero al figlio morto. Perché una parte del suo cervello sta sempre lì, perché una parte della sua vita è finita, morta, e rivive imperfetta nelle inutili metodiche consolatorie azioni della domenica in quel luogo freddo e grigio, pieno di occhi morti che la guardano. Allora vince il paradosso dei gesti e pulendo la lapide, o sistemando i fiori, Wilma guarda la foto del figlio nel marmo, e sta bene. Si guarda intorno e capisce che è uguale a tutti gli altri, che la sua tragedia personale è il pass per stare in mezzo a gli altri. Uguale a tutti gli altri. Allora finalmente si allenta la morsa al cervello che le stringe l’anima. Tira via il fiato dai polmoni e cammina anche più leggera… lì dentro. E’ fuori il cancello del cimitero che la morsa riprende a stringere, che il passo diventa stanco, che i polmoni si riempiono d’aria pesante. Lei non lo avrebbe mai lasciato solo in quel posto fatto di tanti occhi; non l’avrebbe abbandonato al freddo, all’acqua, al vento fischiante, ma oramai Iuri non c’è più. Però c’è un altro figlio, Melania. È ribelle, bizzarra, sovversiva, ha sempre con sé un cane puzzolente e frequenta una setta satanica.
Il rapporto madre figlia è dei peggiori. Governato dalle incomprensioni, dalla gelosia e dai silenzi. È questa la descrizione pratica del dolore di chi sopravvive. Del dolore di chi affronta una tragedia sconvolgente, ma che è sempre meno tragedia dell’altra. Il dolore per la perdita di un fratello infatti non è paragonabile a quello della perdita di un figlio per una madre, però quando in una famiglia si materializza lo spettro della morte, chi resta deve far i conti con il dolore degli altri, fino ad annullare il proprio stesso diritto alla sofferenza. È quello che fa Melania e la sua strampalata vita è la semplice reazione del dispiacere di una figlia, a quello della madre sopraffatta dal dolore.
Dinamiche vere! Tremendamente vere, orribilmente vere, e Marilù Oliva è stata brava a gestire questo turbinio di sentimenti ricco di amarezza, di silenzio, di incomprensioni. Ricco dell’inutile assurdo vivere che avvolge le vite dei sopravvissuti al dolore. Mi riferisco alla povera figlia di Wilma e al suo zaino, e al suo cane, e alla sua angoscia ricacciata ossessivamente dentro, al suo cercare ovunque un fratello che non c’è, senza ammettere di cercarlo, e insieme a questo cercare una famiglia che non c’è più, una mamma che non è più sua, perché travolta dal dolore e con il pensiero ossessivo di fare qualcosa per suo figlio che non c’è più. Sommergendosi di dolore e sommergendo col suo il dolore degli altri.
Brava Marilù, il tuo libro l’ho apprezzato molto e molto ho amato queste parti dove l’incomprensione distrugge i rapporti familiari vivi. Sei stata brava a descrivere tutto solo con piccoli fatti, o accenni, senza mai esprimere un parere, statuire o dissertare; facendo parlare solo i gesti quotidiani: l’umanità dei gesti obbligati. Al lettore sensibile e attento cogliere l’immersione in questo tormento reale da cui tutto parte e dove tutto finisce. A te tutti i miei migliori complimenti.
Ti è piaciuto l'articolo? Iscriviti alla newsletter
Inserisci la tua email e riceverai comodamente tutti i nostri aggiornamenti con le novità, le anticipazioni e molto altro.