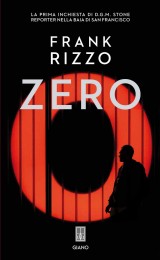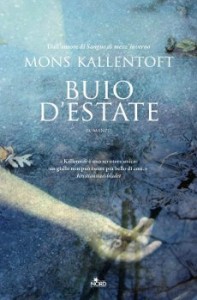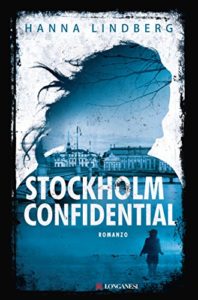Un tipo dai mille talenti, Charles Willeford.
Potete giurarci.
Nato in Arkansas nel 1919 e rimasto orfano in tenera età, vagabonda per gli Stati Uniti insieme alle comunità hobo fino ai sedici anni, quando si finge maggiorenne per arruolarsi nei corpi a terra dell’Aeronautica e intraprendere una carriera militare che gli frutterà innumerevoli onorificenze e medaglie al valore. Abbandonato l’esercito dopo un ventennio in trincea, sbarca il lunario grazie ai mestieri più disparati: allenatore di cavalli da corsa, pugile, speaker radiofonico e pittore, occupazioni di fortuna attraverso le quali acquisisce un visuale privilegiata su quell’umanità ai margini, distorta ed inquietante, che saprà trasporre tra le sue righe con dovizia di particolari e cinismo di difficile emulazione. Nonostante la feconda bibliografia (25 pubblicazioni tra il 1948 e il 1988), Willeford deve la sua affermazione principalmente allo sgangherato, quasi tragicomico detective Hoke Mosley, mattatore nel quartetto di romanzi pubblicato tra il 1984 e il 1988 che compone la “tetralogia di Miami”: “Miami blues” (1984); “Tempi d’oro per i morti” (1985); “Tiro mancino” (1987); “Come si muore oggi” (1988). È del 2018 la scelta di Feltrinelli di ristampare “Tiro mancino”, il terzo e con ogni probabilità più maturo capitolo della saga.
Hoke Mosley e Stanley Sinkiewicz. Uno statunitense purosangue e un immigrato polacco. Un poliziotto depresso e un pensionato sprovveduto. Due destini che si incrociano fatalmente tra le palme di Miami, Riviera Beach e Singer Island. Hoke Mosley è stanco. Sfiancato. Sta raschiando il fondo. Ne ha piene le scatole delle scartoffie sui casi irrisolti che il capo gli accatasta sulla scrivania come volantini e della pressante routine che gli impone il suo ruolo di sergente investigativo in forza alla Omicidi di Miami. Una mattina, nella monofamiliare di Green Lakes che condivide con la collega Ellita Sanchez e con le figlie Aileen e Sue Ellen, accusa un attacco da “sindrome di sfinimento da battaglia”, una specie di corto circuito che lo relega a uno stato semi vegetativo, incapace di parlare, muoversi, perfino di gesticolare. I suoi superiori decidono di spedirlo a trascorrere un mese di permesso non retribuito a casa del padre Frank, un anziano commerciante che ha fatto fortuna investendo nel mercato immobiliare di Singer Island, florida isoletta al largo di Miami in cui l’anziano vive con la bellissima moglie (non moglie, in realtà) trentenne Hellen. Ristabilitosi, Hoke si determina a dare una sterzata alla propria esistenza e dimettersi dalle forze dell’ordine per amministrare il “Pelicano Arms”, uno dei numerosi residence di proprietà del genitore, dove si imbatterà in una parata di inquilini irrequieti tutt’altro che convenzionale: addestratori di elefanti, studiosi di tafani etiopi, lavapiatti di albergo con la passione per le ragazzette in carne. Finché un delitto inatteso lo riporterà sulle strade a tallonare i criminali, pistola in pugno e solita, inseparabile dentiera a ballonzolargli tra le labbra.
Stanley è il figlio prediletto della classe media americana. Ha tutto dello yankee, salvo i natali. Emigrato a Detroit in cerca di fortuna, reperisce un impiego da verniciatore alla Ford Motor Company, alla quale dedica quarant’anni del suo onesto e indefesso lavoro. Guida un’auto americana. Acquista prodotti americani. Si appassiona soltanto a programmi televisivi americani. Un simpatico vecchietto dagli occhi a stelle e strisce che si gode la pensione a Riviera Beach, Florida, insieme alla moglie Maya, gironzolando per centri commerciali, piantonando giardinetti pubblici, tendendo agguati ai randagi di quartiere con il suo bastone da passeggio caricato al cianuro; un lento incedere destinato a naufragare quando, a causa di un madornale fraintendimento, Stanley viene arrestato con l’incriminazione di violenza sessuale su minore. Nella sua notte al fresco, condivide la cella con Troy Lauden – Robert Smith per i nemici -, un istrionico scavezzacollo che gli snocciola qualche dritta per ottenere una scarcerazione immediata e prende a inculcargli le sue strambe ma affascinanti teorie sul mondo, sulle femmine e sull’arte del delinquere, mettendo in atto un’opera di convincimento talmente raffinata che per Troy sarà un gioco da ragazzi coinvolgere l’indifeso Stanley in un lavoretto a un supermarket di Miami.
“Tiro mancino” soffre etichettature di sorta, come capita a qualsiasi opera di rottura. Non rispecchia i canoni del giallo, del crime o del noir in senso stretto, ne rappresenta piuttosto un’equilibrata miscela che l’autore combina pescando dai singoli generi a seconda delle esigenze contingenti. È così che la trama, semplice e lineare, può poggiare su un’intelaiatura narrativa composita, che si srotola in una scrittura in punta di penna, ipnotica, elegante, in grado di risucchiare il lettore nell’acquitrino che ristagna nelle coscienze dei protagonisti, ancor prima che nelle loro rocambolesche disavventure. Vincitori o perdenti poco conta, ciascun attore uscirà sconfitto: chi con un cavalletto e una tavolozza insanguinati, chi con la faccia tumefatta, chi con un biglietto per Haiti su cui piangere, chi con un proiettile di troppo ficcato nel punto sbagliato. Non necessariamente in mezzo alle sopracciglia.
Sì, perché sarà bene essere chiari: meglio tenersi alla larga dagli scaffali che custodiscono i volumi di Willeford, se si cerca un thriller tutto piombo, sparatorie e narcosanti. Più che il crimine in sé, tra i paragrafi del talento di Little Rock si scandagliano i meccanismi che giustificano e fortificano la tendenza a deviare, le repressioni soffocate e le aspettative disattese, i se, i ma, i semmai, l’insieme di quei germi del subconscio che rosicchiano le inibizioni e spingono una massaia a imbracciare un canne mozze o un vecchio sdentato a premere un grilletto; l’indagine non si sviluppa al freddo di una sala autoptica o in fumose stanze da interrogatorio, si snoda tra i serpeggianti dedali delle menti corrotte, limando encefali e scavando cervelletti. Incoccia le loro pareti a specchio. Incespica nei pavimenti crepati. Rimbalza contro i muri come una biglia impazzita. E in un contesto simile persino la “filosofia dello psicopatico” che Troy Lauden propina a Stanley e ai suoi faccendieri – un pittore rappresentativo haitiano e una prostituta deforme – acquista il tenore di un dogma di fede: “la differenza tra il bene e il male la so distinguere – si descrive con fierezza – ma non mi fa né caldo né freddo. Se vedo la cosa giusta e mi va di farla, la faccio; se invece vedo quella sbagliata, e mi va di farla lo stesso, faccio anche quella”.
In fin dei conti il leitmotiv sta qui: quanto è labile il confine tra una scelta giusta e una sbagliata?
Se vi interessa saperlo, date retta a me.
Imbarcatevi su un volo per Miami con la VISA in tasca.
Noleggiate un’auto e imboccate la statale per Riviera Beach.
Godetevi il panorama di una Florida disillusa, i suoi lampioni guasti e i giardinetti incolti.
Parcheggiate a uno spaccio di liquori, dove Troy Lauden starà minacciando un inserviente con una doppietta artigianale.
Offritegli una birra ghiacciata e chiedete a lui: riuscirà a darvi una risposta convincente.
E magari assegnarvi un compito per il prossimo colpo.
Come al solito.
Recensione di Lorenzo Garzarelli.
Ti è piaciuto l'articolo? Iscriviti alla newsletter
Inserisci la tua email e riceverai comodamente tutti i nostri aggiornamenti con le novità, le anticipazioni e molto altro.